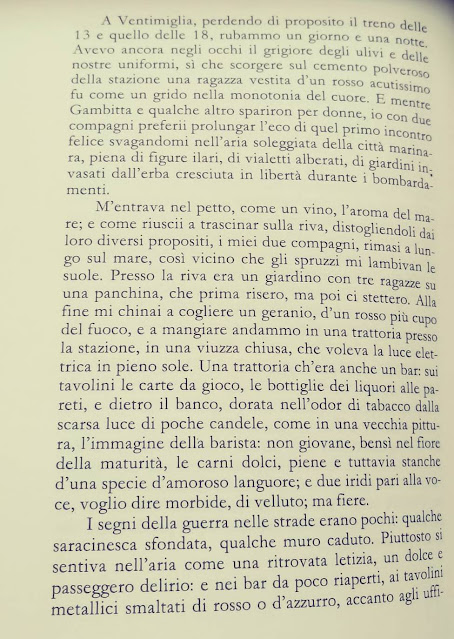|
| Joffre Truzzi - Fonte |
Intanto l’onda lenta del mare si ripropone nei momenti di maggiore quiete, come una carezza, nel volgere di uno sguardo; e ripenso allora a quell’onda ben più vigorosa e veloce, ricca di bianca schiuma che la corrente, delle nostre mareggiate di ponente, scaraventa fino ai muraglioni della passeggiata e oltre. Rivedo la bianca distesa di schiuma correre, ormai placata, verso terra e poi improvvisamente, incontrando un ostacolo, impennarsi con una forza inaspettata verso il cielo e rifrangersi quindi in mille rivoli bianchi ricchi di veemente allegria. Ecco, dico fra me, ecco: quel ricciolo impetuoso e arrabbiato potrebbe essere Truzzi, e tutti quegli schizzi bianchi successivi, la sua allegria e la sua raggiunta dolcezza. Così mi piace vederlo, affrontare la risacca della vita, e destreggiarsi in essa.
Ci spostiamo nello studio del pittore e qui, sulla soglia, sono investito da un’onda di luce calda senza che nessuna lampada fosse stata accesa. Le tele sono appoggiate per terra contro le pareti, alcune, appese lungo le stesse; Joffre non indugia a commentare i suoi lavori; ascolta e guarda con me. Alle sue spalle, come arrampicato su una scala di metallo, sento, e poi vedo, lo sguardo ammiccante di un suo bel autoritratto. Mentre usciamo dalla stanza gli chiedo di Bordighera, dei suoi amici, dei suoi « colleghi» pittori, degli artisti in genere; di Bordighera degli anni prestigiosi (1950-1970), dei Premi 5 Bettole e degli avvenimenti importanti; non spende molte parole in proposito; ma ricorda volentieri alcuni nomi che gli sono cari, come Giuseppe Balbo, prezioso animatore di tante iniziative, e, altri, per il loro rilievo nel campo della cultura e dell’arte: Carlo Betocchi, di cui rievoca la grande ospitalità offertagli nella sua casa fiorentina di Borgo Pinti, nel 1957, Giacomo Ferdinando Natta, arguto e colto conversatore; Sbarbaro, Biamonti, Carlo Bo, Giancarlo Vigorelli, Lorenza Trucchi, Italo Calvino, tutti gravitanti qui e poi, quasi per un segreto appuntamento, tutti da Maria Pia Pazielli alla sua Piccola Libreria. Gli occhi, ad un certo punto, si intristiscono, un altro nome gli affiora sulle labbra: Luciano De Giovanni, il poeta sanremese scomparso da pochi anni cui lo legava una profonda amicizia. Riesco a stento a leggere alcune parole di una poesia che De Giovanni gli ha dedicato; uno dei suoi sonettini del 1986: «… e il cielo che vortica lento/ le sue nuvole e il suo azzurro / e la barriera dei monti e gli ondulati dorsali/ e le segrete fonti». Degli amici d’oggi Truzzi ricorda in particolare Enzo Maiolino, Sergio Gagliolo, Sergio Biancheri; nomi legati all’arte e alla vita, alla comune visione naturale di questa aspra e semplice terra di ponente. Ricorda Morlotti e ancora Biamonti, e la gita che fece con lui e Maiolino nei luoghi di Cézanne. Si illumina infine parlando di Piana, e batte la mano sul tavolo in segno di grande stizza e ribellione quando denuncia il persistente oblio che circonda questo pittore di grande valore e straordinaria modernità. Il commiato si avvicina e Joffre appoggia la sua mano sul mio braccio, mi fissa negli occhi e mi dice risoluto: «ricordati che chi non é sincero nella vita, non lo é neppure nell’arte», una bella verità pronunciata da un uomo «vero».
Starei ancora a lungo, accarezzando il silenzio come si accarezzano le nuvole che incorniciano i nostri tramonti nei loro inesorabili mutamenti. Un’ultima occhiata al tavolo di Truzzi: una fotocopia un poco gualcita ricorda una mostra del pittore alla Biblioteca di Ospedaletti nel 1996; una foto ricordo degli anni ’60 con Morlotti e Biamonti, un breve scritto di quest’ultimo, intenso e ricco di significato umano per Truzzi, «… un uomo sempre disponibile al lavoro, alla vita, sempre pronto a partire, verso una tomba, un rudere, un fiore. Poteva anche essere insopportabile, litigioso, in superficie, ma a Morlotti e a me, strappava sempre il sorriso, perché ne conoscevamo la malinconia fondamentale».
Luigi Betocchi, Quel ricciolo bianco dell'onda, Sito dedicato alla figura di Joffre Truzzi, settembre 2005
 |
| Da sinistra: Giuseppe Balbo, Giuseppe Piana e Joffre Truzzi - Fonte |
 |
| Joffre Truzzi, Pescatori, 1955 (olio su tavoletta) - Fonte |
Redazione, Un po’ di storia, Accademia Riviera dei Fiori "Giuseppe Balbo", 2011
 |
| Joffre Truzzi, Paesaggio - Fonte |
[...]
1.5. SCRITTI DI CRITICA D’ARTE
[...]
1977
(1977a) = [Presentazione], in J. Truzzi, Teatro Comunale, Ventimiglia, 15-28 gennaio 1977 [dépliant della mostra].
[...]
1996
(1996a) = [Presentazione], in Joffré Truzzi. I pittori del Ponente 5, Biblioteca Civica, Ospedaletti, 5-25 aprile 1996 [dépliant della mostra]; poi, parte dello scritto (righe 25-33), in Joffré Truzzi, presentazione della mostra personale al Palazzo del Parco, Bordighera, 28 novembre-5 dicembre 2002 [dépliant della mostra]; poi, con il titolo Truzzi, i paesaggi sospesi nel vuoto, in SP (213).
Matteo Grassano, Il territorio dell’esistenza. Francesco Biamonti (1928-2001), Tesi di dottorato, Université Nice Sophia Antipolis, Università degli Studi di Pavia, 29 gennaio 2018
 |
| Joffre Truzzi, Val Nervia, 1988 - Fonte |
Ma il cielo e la luce della città delle palme incantano anche Ennio Morlotti, alla ricerca di una “nuova avventura” pittorica. Boschetti di ulivi e di limoni, rocce, cactus, lingue di spiaggia bagnate dal mare: è questo il paesaggio ligure che Francesco Biamonti e Sergio Biancheri, conosciuti nel 1959, mostrano al pittore lombardo durante i numerosi viaggi in automobile. Le campagne di Borghetto San Nicolò e Vallebona, la Val Nervia, gli scogli di Marina San Giuseppe, il pianoro di Punta Migliarese, Perinaldo e, ovviamente, San Biagio della Cima diventano mete da visitare ogni estate, alla scoperta della luce e dei grumi di colore di cézanniana memoria che tanto affascinano sia Morlotti sia Biamonti (si ricordi la loro visita, in compagnia di Maiolino e Truzzi, allo studio di Cézanne a Aix-en-Provence nel 1963).
Mara Pardini, La cultura nel ponente ligure ai tempi di Francesco Biamonti: un accenno, Terra ligure
[...] Il padre Satiro, lavorava alla costruzione della ferrovia
Trans-Canada, che doveva unire la Costa Atlantica con il Pacifico, con
temperature proibitive e condizioni di lavoro disumane; alla fine il
povero Satiro non ce la fece, e dopo dieci anni dovette rientrare nella
nativa Mantova, terra dei Gonzaga, dove fiorivano le arti e
l'artigianato.
La madre Stella, donna indomita e coraggiosa, accudiva
Joffre, i suoi fratelli e la casa di tronchi d’abete, e, per "fare la
spesa", usciva a cavallo nei boschi con la doppietta e a volte tornava
con un bottino di selvaggina o solo bacche del bosco.
Ancora
adolescente, Joffre tornò nella terra dei suoi avi durante un viaggio
periglioso, dove rischiarono di affondare e di contrarre qualche brutta
malattia contagiosa, stipati com'erano nella stiva di un'ansimante
piroscafo.
Nei ricordi di Joffre questo periodo della prima infanzia è
vago, ma sempre presente, come visioni, fra sogno e realtà. E sono
convinto che ha creato i prodromi di quest’inusuale artista e
personaggio eccezionale, temprato dai grandi freddi, con la visione di
grandi spazi e di aurore boreali,che a novant'anni dipingeva ancora
attivamente.
Nelle mattine soleggiate lo trovavi al suo bar preferito
dei Piani di Borghetto, a gustarsi uno "spruzzato" e a scambiare sagaci
commenti sul via-vai del marciapiede, ma soprattutto, ti sorprendeva
con la sua memoria e la profonda cultura, assimilata in viaggi e
letture, con una sempre viva curiosità.
Scontroso e irascibile
superficialmente, nascondeva un animo gentile e mite, timido, che
proteggeva con questa "corazza" burbera e accigliata.
Spirito di
contraddizione e in contraddizione con il mondo e con se stesso, anche
con i suoi affetti e amici più cari, si realizza e trova sfogo e pace
nei suoi dipinti. Che a veder bene, è una una vera stranezza, che non
abbiano avuto il successo e i riconoscimenti che meritano.
Ci sono le
ragioni di questo "tesoro" nascosto: sicuramente il carattere scontroso
e introverso non ha favorito il necessario supporto di critici e
galleristi, oltre alla scelta di vita e di lavoro nella dolce e pigra
Riviera di Ponente, senza mai spingersi, non dico all'estero, ma nemmeno
a Milano, a cercare e sviluppare contatti e amicizie.
Sono riuscito a
portarlo a Parigi e Londra, solo dopo gli ottant'anni, dove ha visitato
i grandi musei e ha avuto anche un grande successo con un'esposizione a
Oxford.
Lo stesso Morlotti, che frequentava e lo stimava molto, era
in continuo movimento pur passando molto tempo in Riviera ed aveva
solidi rapporti con importanti galleristi che lo aiutarono ad
affermarsi, anche con accordi commerciali, che il nostro Truzzi
disdegnava.
Quando qualche critico o gallerista "scopriva" Truzzi, il
rapporto quasi inevitabilmente si deteriorava e infine si interrompeva,
grazie alle intransigenti posizioni del nostro integerrimo e scontroso
Maestro!
Se non sei un buon diplomatico non vuol dire che non puoi
essere un buon artista, anzi! Forse non avrai mercato e fama, ma le
opere rimangono e testimoniano una produzione artistica di alto livello.
Truzzi
ha visitato musei, esposizioni, chiese, paesi e, soprattutto, ha
incontrato molta gente comune “la più vera”, con cui amava dialogare con
vivace spontaneità e ha sempre letto molto.
Se Truzzi non ha
accettato compromessi per affermare la sua arte, si é impegnato a
soddisfare la sua cultura e curiosità e per guardarsi nello specchio
ogni mattina serenamente.
La sua pittura è stata sicuramente ispirata
dai grandi impressionisti, soprattutto Cezanne, di cui ha visitato lo
studio a Aix-en-Provence con Morlotti e Francesco Biamonti, e da De
Stael, di cui amava molto i cieli, ma anche dall'amico Morlotti.
In
Truzzi si è sviluppato misteriosamente un fenomeno di osmosi, tra le
atmosfere mediterranee del nostro entroterra, cosi amate e descritte da
Biamonti, con i suoi paesaggi ventosi, e un post'impressionismo materico
magistrale, che solo sfiora l'informale, vedi le bagnanti e i nudi, che
sono un'amalgama poetico di carne, di terra, di acqua e di vegetazione,
un'atmosfera e un pathos legato all'ultimo Cezanne, e oltre, proprio
per quel suo sfiorare, accarezzare quasi l’informale, ma senza mai
cedere alle sue facili lusinghe.
Come gli impasti materici, ma tenui,
delicati, dei fiori di Truzzi, le "sue" rose canine che andava a cercare
tra i muretti a secco, sopra Sasso e Seborga, o i limoni lucidi di
humus, di una materia così viva e "profumata" lavorata con perizia tra
spatole e ruvidi pennelli.
Truzzi ama dipingere su superfici dure,
solide, dove sente il bisogno di "affondare" il suo segno con il
pennello o la spatola, ma anche con la viva mano, l'indice che penetra
nella materia ancora duttile e la segna in profondità: così Truzzi si
lega alla sua opera, in un’indelebile simbiosi.
Quasi alla fine della
sua lunga vita, Truzzi riscopre l’Eros e dipinge una serie di grandi
bagnanti, Angeli-Maddalene di un sogno erotico, di carni impastate col
fango, la vita, l’eros, e la morte... sul solco tracciato da Renoir, e
prima ancora da Tiziano e Rubens,soggetto al quale si dedicò anche
Morlotti, nelle ultime sue opere.
Ho avuto la fortuna di frequentare
Truzzi per molti anni, da quando scorazzava altero sul suo
Galletto-Guzzi. Abbiamo visitato Roma in lungo e in largo, dove amava
passeggiare in via Giulia, perché gli ricordava un racconto di
Caldarelli; a Firenze, dove riconosceva a prima vista gli affreschi
delle Chiese, con nomi e date; a Ferrara, al Palazzo dei Diamanti, per
una grande mostra, la prima postuma, di Morlotti e a Venezia, dove amava
rivedere più volte la "Resurrezione" del Tiziano, con quella luce
verdastra, dipinta a novant'anni [...]
Daniel Audetto, Joffre Truzzi, Sito dedicato alla figura di Joffre Truzzi, luglio 2013