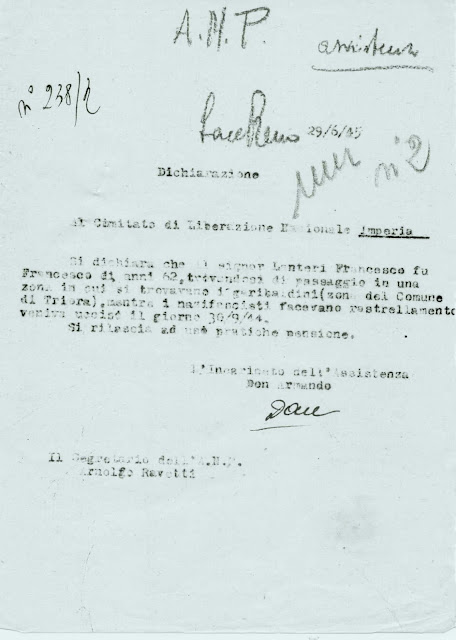|
Fornovo di Taro (PR). Fonte: Wikipedia
|
Nei concitati giorni della proclamazione dell’Armistizio anche il Comitato d’azione antifascista parmense intensifica gli sforzi. In una riunione tenutasi a Mariano il 9 settembre, nella villa del professor Angelo Braga, viene presa la decisione di coordinare gli sforzi degli esili gruppi antifascisti presenti sul territorio e cominciare ad organizzare una concreta opposizione agli occupanti <8. Da subito il nascente CLN si impegna per offrire aiuto e sostegno logistico ai militari alleati in fuga dai campi di prigionia, cercare armi, imbastire una rete di contatti. Il 15 ottobre, nello studio dell’avvocato Francesco Micheli, dirigente del Partito Popolare ed esponente di spicco dell’antifascismo parmense, si costituisce formalmente il Comitato di Liberazione Nazionale di Parma, struttura provinciale di organizzazione e coordinamento della nascente lotta antifascista. Ne fanno parte comunisti, socialisti, cattolici, repubblicani, liberali, azionisti <9.
Il CLN così costituito deve preoccuparsi di imbastire un’efficiente rete di comunicazioni con i centri del movimento partigiano. Ad attendere a questi compiti sarà un esercito di staffette, che costituiranno, per tutti i mesi della lotta partigiana, i nodi fondamentali di una rete clandestina di comunicazione e informazione. Le staffette sono tradizionalmente, nella memorialistica sulla Resistenza, donne. Per loro era forse più semplice muoversi liberamente sul territorio, destando minori sospetti dei colleghi maschi. Un compito importante che però non esaurisce la varietà dei ruoli ricoperti dalle circa 460 resistenti riconosciute in Provincia di Parma che, per tutti i mesi della lotta partigiana, cureranno feriti, faranno opera di propaganda, consegneranno stampa clandestina, organizzeranno manifestazioni pubbliche, prenderanno parte a combattimenti <10.
All’indomani dell’Armistizio si pongono anche le basi per la formazione delle squadre SAP (Squadre di Azione Patriottica) e GAP (Gruppi d’Azione Patriottica), vere e proprie cellule partigiane clandestine dislocate in città, composte da persone che, anziché abbandonare le proprie case e unirsi alle bande della montagna, continuano a vivere nella propria dimora e mantenere un normale impiego, dietro cui mascherano l’attività di guerriglia, sabotaggio e spionaggio.
Al progressivo consolidamento delle forze antifasciste si accompagna la rapida stabilizzazione del potere tedesco in città: tra settembre ed ottobre il controllo militare e amministrativo della provincia di Parma passa nelle mani del Militärkommandatur 1008, l’amministrazione militare tedesca, stabilitasi a ridosso della Cittadella, tranquillo quartiere residenziale lontano dai possibili obiettivi dei bombardamenti alleati <11.
[NOTE]
8 Gorreri D., Parma ’43. Un popolo in armi per conquistarsi la libertà, Parma, Step, 1975.
9 Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma, I caduti della Resistenza di Parma 1921-1945, Parma, Step, 1970, p. 159.
10 Pieroni Bortolotti F., Le donne della Resistenza antifascista e la questione femminile in Emilia Romagna: 1943-1945, Milano, Vangelista, 1978.
11 Klinkhammer L., Una città sotto l’occupazione tedesca: il caso di Parma, in «Storia e documenti», 5, 1999.
Iara Meloni, Occupazione tedesca e lotta di Liberazione a Parma: una breve introduzione storica in Stefano Rotta, Partigiano Carbonaro. Un ragazzo nella Prima Julia, Parma, Graphital, 2015
In questo capitolo ci si vuole soffermare e analizzare in che modo era strutturato il movimento partigiano parmense e che tipo di rapporti intercorrevano tra i comandi (e organismi) provinciali e quelli regionali o nazionali. Non vuole essere questa la sede per analizzare le caratteristiche e le criticità dei Comitati Nazionali come il CLN o il CLNAI, che sono invece stati ampiamente ed egregiamente trattati da storici come Roberto Battaglia, Claudio Pavone o Santo Peli. <46 Al di là quindi degli organi nazionali, ciò che interessa è focalizzarsi su quelli locali, cercando di dipanare la complicata rete di rapporti interni alla provincia di Parma ed esterni ad essa.
Nel precedente capitolo si è visto come il movimento resistenziale, sin dal suo esordio, sia stato guidato da un organizzazione a carattere nazionale, il CLN <47 appunto, che rappresentava quindi il vertice delle gerarchie di comando. Da questo organo si diramavano e si collegavano tutti i vari Comitati Nazionali sorti nelle città; nel caso di Parma, ricordiamo, questo si formò il 15 ottobre 1944. La fitta rete di collegamenti, non passava direttamente dal CLN nazionale a quelli locali, ma si rapportava anche con organi intermedi, a carattere regionale; per l’Emilia Romagna, era il caso del CUMER (Comando Unico Militare Emilia Romagna). La costituzione dei Comandi regionali si deve all’iniziativa comunista che propose, scrive Battaglia, “di trasformare le vecchie giunte militari in Comandi veri e propri, dotati della necessaria autonomia” <48. I Comandi regionali erano modellati sulla base del Comando Centrale, alle dipendenze del CLNAI, che nacque il 9 giugno 1944 con la costituzione del “Comando Generale per l’Alta Italia occupata del Corpo volontari della libertà” <49.
Alla costituzione del CVL, corrispose una spartizione delle competenze: sommariamente, le attribuzioni del CLNAI erano principalmente di natura politica, quelle del CVL, di carattere militare <50. Al pari di quello centrale, anche i Comitati di Liberazione provinciali e i Comandi locali si basavano su questa divisione. Nel caso parmense, si è visto come nel marzo del 1944, per motivi organizzativi, dal CUMER si formò la Delegazione Nord Emilia, con competenza sulle province di Parma, Reggio e Piacenza <51. I contatti con il Comando Delegato avvenivano grazie alla costituzione a Fornovo, un paese della provincia parmense, di un Centro Collegamenti del Comando Nord Emilia, nel giugno 1944, affidato ai partigiani Bertini (Bruno Tanzi), Ferrarini (Enzo Costa) e Sergio (Alceste Bucci).
Per completare, sommariamente, il quadro dei rapporti tra la provincia parmense e gli altri organismi presenti sul territorio, è doveroso accennare anche alla presenza del Comando Alleato. Nonostante la scarna documentazione a riguardo, Leonardo Tarantini ci informa del fatto che i primi abboccamenti con gli Alleati risalivano al Natale del 1943. <52
I principali contatti con il Comando angloamericano avvennero per gli accordi relativi agli aviolanci; solo negli ultimi mesi prima della Liberazione, il Comando Alleato interverrà in una questione politica interna al Comando Militare parmense, questione che verrà analizzata successivamente, nel presente capitolo.
La gerarchia di comando non riguardava solo l’assetto nazionale, ma si riproponeva anche a livello provinciale. Nel caso di Parma, al pari delle altre città, il movimento era al suo interno rigidamente suddiviso. All’ultimo gradino della scala piramidale si collocavano le Brigate, gerarchicamente divise in Battaglioni, a loro volta suddivisi in Distaccamenti. Ogni reparto, ricordiamo, aveva il suo Comando composto dal Comandante, il Commissario, i rispettivi vice, l’Intendente e il Capo di Stato Maggiore. Salendo nella scala, al gradino intermedio, si posizionavano le Divisioni. Si tratta di raggruppamenti composti da diverse brigate, che si formarono nel parmense a partire dal febbraio 1945. Una relazione dell’ Ispettore del Nord Emilia, Umberto (Umberto Pestarini), ci informa sui motivi della riorganizzazione in Divisioni: “questo ultimo provvedimento, quello delle Divisioni, fa parte di un piano organico di riforma disciplinare e di dislocazione delle nostre forze […]”. <53 Naturalmente anche le Divisioni avevano il loro Comando. Infine al gradino più alto si trovava il Comando Unico Operativo, che coordinava le Brigate dipendenti e interagiva con i Comandi superiori. A differenza che per le vicine Piacenza e Reggio, a Parma si costituì la Delegazione del Comando Unico, operante nella zona ad Est della Cisa; in teoria essa era subordinata al Comando Unico, ma di fatto operava come autonoma. Sulle mansioni e le questioni inerenti al Comando Unico verrà dedicato un ampio paragrafo del capitolo.
[NOTE]
46 Cfr. R. Battaglia, Storia della resistenza Italiana, S. Peli, Storia della resistenza in Italia, C. Pavone, Una guerra civile.
47 sarebbe più preciso dire il CLNAI dal momento che a partire dal maggio 1944, “si considera a tutti gli effetti rappresentante del governo legittimo” cfr. R. Battaglia, Storia della resistenza italiana, p. 333.
48 R. Battaglia, Storia della resistenza italiana, cit. p. 339.
49 Ibidem
50 Per un approfondimento cfr. R. Battaglia, Storia della resistenza italiana, p. 439.
51 Il Comando Nord Emilia era così composto: Comandante: Mario Roveda (Bertola), Commissario: Emilio Suardi (Rinaldi), Vice Comandanti: Amerigo Clocchiatti (Lamberti) e Giovanni Vignali (Bellini), Ispettori: Enzo Costa (Ferrarini) e Bruno Tanzi (Bertini). Cfr. Fernando Cipriani, Guerra partigiana: operazioni nelle provincie di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, p.7.
52 Cfr. L. Tarantini, Resistenza armata nel parmense, p. 67.
53 Archivio dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma (d’ora in poi AISRECP), Fondo Lotta di Liberazione, busta RI, fasc. QC, f. 19.
Costanza Guidetti, La struttura del comando nel movimento resistenziale a Parma, Tesi di laurea, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Anno Accademico 2017-2018
A Parma l'attività militare cittadina fu pressoché inesistente fino al 24 febbraio 1944, quando in centro venne ucciso un milite della GNR. Queste difficoltà di azione trovano conferma da quanto riportato nella Relazione della 12ª Brigata Garibaldi, che attribuiva ai GAP unicamente un'azione di recupero di armi per la montagna nel febbraio 1944. Eugenio Copelli “Gianni”, catturato dalla polizia in un'osteria del quartiere Oltretorrente nella serata del 9 marzo 1944 e ucciso subito dopo, veniva indicato quale comandante dei GAP di Parma da un volantino che lo descriveva come un eroico gappista, ma alla prova delle carte d'archivio risulta che dal colpo di febbraio fino al 10 aprile - quando sulla strada Parma-Colorno venne ferito gravemente da un ciclista un milite della Gnr - non si verificò più nessun attentato. Un ultimo colpo di coda del gappismo parmense si ebbe tra i mesi di maggio e luglio 1944, quando vennero segnalate dai Notiziari della GNR alcune sparatorie compiute da ignoti in bicicletta contro militi della RSI.
Maria Grazia Conti, Gruppi di azione patriottica (GAP) in Comando Militare Nord Emilia. Dizionario della Resistenza nell’Emilia Occidentale, Progetto e coordinamento scientifico: Fabrizio Achilli, Marco Minardi, Massimo Storchi, Progetto di ricerca curato dagli Istituti storici della Resistenza di Parma, Piacenza e Reggio Emilia in Rete e realizzato grazie al contributo disposto dalla legge regionale n. 3/2016 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento”
Nella provincia di Parma le SAP si organizzarono a partire dall'estate del 1944 nella zona della bassa parmense limitrofa ai paesi di Colorno, Roccabianca, San Secondo e Mezzano di Sotto. Durante l'estate esse disarmarono alcune caserme, effettuarono frequenti sabotaggi alla rete telefonica, alle linee ferroviarie e ai cartelli stradali e sparsero sulle principali vie di comunicazione chiodi antipneumatici per bloccare i mezzi nemici, senza però riuscire ad innescare un movimento di massa nelle campagne circostanti. Queste problematiche furono denunciate nel novembre 1944 proprio dal Comando Terza zona che, in una nota al Comando generale delle brigate Garibaldi, lamentava «l'attendismo» delle comunità locali e la sconnessione esistente tra lotta militare e lotta politica. Sempre nel primo autunno del 1944 cominciò ad esserci traccia di nuclei sappisti anche nella zona a sud della via Emilia, ai bordi della città, ma le azioni, anche in questo caso, non andavano oltre qualche disarmo. Come è noto, i grandi rastrellamenti dell'inverno del 1945 costrinsero le SAP a ritirarsi in montagna per impedire gravose perdite di uomini, lasciando la pianura sotto il controllo dei nazifascisti.
Maria Grazia Conti, Squadre di azione patriottica (SAP) in Comando Militare Nord Emilia. Dizionario della Resistenza... op. cit.