Dei patrioti non fece mai nomi veri o di battaglia, ad eccezione di Giuseppe Porcheddu e della sua famiglia, presso cui i due ufficiali britannici, che dopo l'8 settembre 1943 erano riusciti a fuggire dal loro campo di prigionia di Fontanellato in provincia di Parma, trovarono ospitalità clandestina per circa un anno, eccezione fatta per alcuni brevi periodi di più prudente collocazione in altri luoghi; di Renato Brunati, martire della Resistenza, e Lina Meiffret (tornata salva dalla deportazione in Germania, ma minata nel corpo e nello spirito per le tante sevizie cui venne sottoposta in carcere ad Imperia e a Genova, per tanti altri patimenti subiti, per i due falliti tentativi di lasciare la Germania e soprattutto per la perdita dell'amato Brunati), i quali per primi sul finire del 1943 diedero rifugio ai due ufficiali in Baiardo; di Vito (Vitò, Ivano, Giuseppe Vittorio Guglielmo, comandante della II^ Divisione d’Assalto Garibaldi "Felice Cascione"); di Achille, cioé Achille "Andrea" Lamberti del Gruppo Sbarchi Vallecrosia, quest'ultimo tra gli organizzatori della loro esfiltrazione definitiva verso gli alleati con arrivo in barca a remi (a marzo 1945) a Montecarlo.
Del libro di Michael Ross può essere interessante citare alcuni fatti immediatamente antecedenti la fuga finale di Bell e di Ross, fatti successivi al definitivo e necessario abbandono della casa di Porcheddu. Una volta arrivati di nuovo sulle alture della guerriglia, i due rischiarono di essere passati per le armi a causa della profonda, bellicosa diffidenza di un capetto partigiano, ricordato con il nome di Bruno: per loro fortuna tale iniziativa non poteva essere fatta senza l'assenso di Vito (Vitò), il quale, ricorso ad un breve interrogatorio condotto da piloti statunitensi, ebbe modo di appurare definitivamente che si trattava di ex prigionieri dell'Italia fascista e di apprestare loro le misure necessarie al loro viaggio verso la Costa Azzurra.
Per tre volte, a seguito delle comunicazioni via radio fatte dal telegrafista dell’ufficiale di collegamento alleato, il capitano del SOE britannico Robert Bentley, un sommergibile inglese si avvicinò alla costa vicino a Taggia, forse alla Curva del Don di Riva Ligure, già altre volte pensata per simili missioni.
Per due volte la scorta dei partigiani ed il gruppetto degli alleati - tra cui Erickson e Klemme, sui quali esiste una discreta letteratura, piloti alleati caduti con i loro apparecchi in Piemonte ed arrivati in Riviera dopo diverse peripezie - che dovevano imbarcarsi dovettero fuggire perché trovarono i tedeschi che li mitragliarono con l’ausilio di bengala.
All’ultimo appuntamento i nazisti attesero invano, perché nel frattempo i garibaldini avevano individuato la spia che aveva messo in allarme il nemico, una giovane donna, di probabile origine iugoslava, prontamente giustiziata, per giunta con la pistola di un pilota alleato.
Risultarono dispersi, poco prima della loro partenza, due partigiani e due americani, indicati come Ricky e Reg.
Alla fine si compose la squadra che, formata da Ross, Bell e due piloti alleati, sfuggiti alla cattura da parte nazifascista, marciò attraverso l’entroterra di Sanremo, Negi di Perinaldo, Vallebona verso Vallecrosia, punto clandestino di imbarco per la Francia.
 |
| Giovanna Porcheddu ed il marito Michael Ross. Fonte: The Telegraph |
Diversi
anni dopo Michael Ross, quando si trovava a Bordighera (dove alla fine
si era ritirato con la moglie Giovanna, figlia di Giuseppe Porcheddu)
passava spesso a salutare Achille Lamberti o si spostava nell'entroterra
insieme all'amico Vincenzo Manuel Gismondi, il patriota antifascista
che si era recato a Genova per acquistare - con fondi messi a
disposizione da Dino Giacometti di Ventimiglia, dove abitava a Villa
Olga, grande amico di Porcheddu - un motore fuoribordo da applicare alla
barca che, trafugata da Villa Donegani di Bordighera, avrebbe dovuto
trasportare (sembra di capire alla fine del 1943) lo stesso Manuel
Gismondi, gli amici suoi e di Porcheddu Moraglia ed Assandria, Bell e
Ross in Corsica nel primo dei tanti tentativi falliti di rientro nelle
linee alleate compiuti dai due ufficiali britannici: in questo caso per
una falla della barca che a duecento metri dalla riva affondava. Questo
episodio è attestato ("... a stento i fuggiaschi raggiunsero la costa
rifugiandosi poi da me, fradici ed avendo salvato solo il motore") da un
memoriale di Giuseppe Porcheddu, che purtroppo all'Istituto
Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia si trova
solo in fotocopia, mentre secondo David Ross quel viaggio non venne
neppure tentato perché all'ultimo il pescatore che avrebbe dovuto
condurre quel natante si sottrasse all'impegno preso.
Anche il
penultimo tentativo - del Gruppo Sbarchi - di trasferire Bell e Ross e
gli altri alleati (sempre a marzo 1945 e dopo che era già saltato -
testimonianza di Renato Dorgia - l'appuntamento o con un motoscafo o con
un altro sommergibile provenienti dalla Francia) via mare da
Vallecrosia in Costa Azzurra fu bersagliato dalla sfortuna: per la
seconda volta un'imbarcazione colò a picco e fu grosso lo sforzo di
riportare a riva Bell, che non voleva sbarazzarsi dell'ingombrante
cappotto, appesantito dall'acqua, sforzo fatto da Achille Lamberti, che
nell'occasione se ne uscì con la frase che negli anni avrebbe ancora
tante volte pronunciato: "Tùti in tu belin a mi!" (Renato Dorgia in
Giuseppe Mac Fiorucci, Gruppo Sbarchi Vallecrosia, IsrecIm, 2007).
Adriano Maini
.JPG)
.JPG)



.JPG)
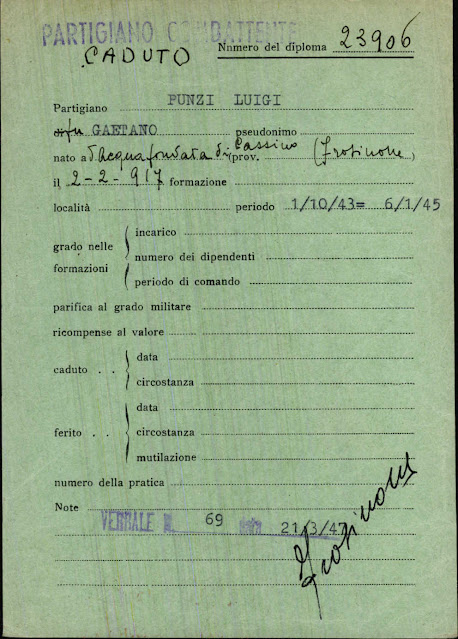
.JPG)




.JPG)


