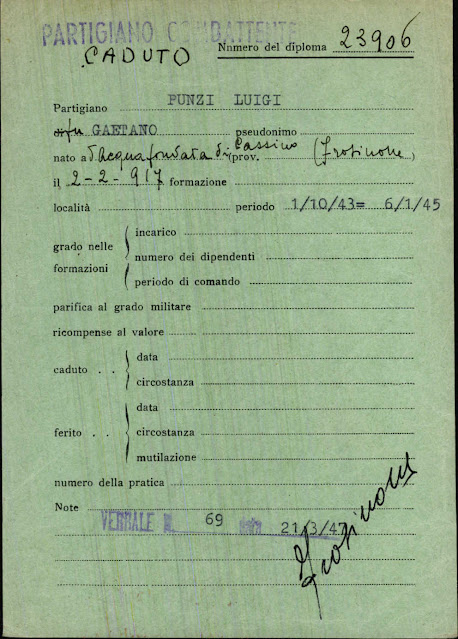Il 20 settembre 1943 a
Milano in casa dei coniugi Morini nacque il Comando generale delle Brigate Garibaldi, alla presenza di Massola, Roasio, Novella, Negarville, Scotti, appena rientrato dalla Francia, e Secchia, giunto da Roma. Nei giorni successivi sarebbe arrivato anche
Longo, mandando Negarville a Roma e assumendo la responsabilità militare delle Brigate del Pci, mentre Secchia era incaricato della guida politica. Nonostante la mancanza di un'effettiva struttura di partito in Italia, si scelse di rompere l'attesismo e lanciare nell'immediato l'attacco all'occupante e al suo collaboratore. Pur con supporti logistici da socialisti e azionisti, in Italia come in Francia, i comunisti risultano gli unici fautori del terrorismo urbano, mentre gli altri partiti antifascisti "non sono convinti della sua produttività, in termini di consenso da parte dei cittadini, e della praticabilità, in termini morali, del terrorismo urbano" <16. Per il PCI invece, l'esperienza di vita clandestina e di lotta in Francia fu di centrale importanza nella decisione di ricorrere a tale pratica, di cui conosceva già le modalità e i fini, ma anche i rischi e le difficoltà. La scelta di ricorrere alla guerriglia in città fu adottata consapevolmente, in accordo con il comportamento dei comunisti a livello europeo e con la convinzione di costituire l'avanguardia del movimento operaio nella liberazione. Una filiazione delle azioni dei
GAP da quelle dei FTP, un filo diretto com'è dipinto da Amendola nel suo panegirico di Ilio
Barontini, può forse essere valido sul piano strettamente personale, apparirebbe invece sul piano storiografico un salto deduttivo, in relazione alle scarse informazioni ufficiali sull'operato degli italiani a Marsiglia.
Per Amendola "l'azione all'albergo Terminus divenne l'azione compiuta dai Gap romani contro l'albergo Flora, con la stessa tecnica e l'ordigno gettato davanti alla coda della casa di tolleranza di Marsiglia, divenne l'ordigno gettato da Bentivegna davanti al cinema Barberini a Roma" <17.
Questi eventi potevano forse essere legati nella memoria del protagonista, che si servì del precedente di alcune azioni realizzate in Francia da comunisti italiani per la guerriglia in patria, ma, in assenza di testimonianze e riscontri documentari, tali parallelismi non possono valere sul piano storiografico. Si può tuttavia riconoscere che le strutture di un organismo già noto servirono da modello alla preparazione delle squadre deputate al terrorismo nelle città italiane. Santo Peli riconosce l'imprescindibilità dell'esperienza francese all'inizio della sua storia dei GAP, asserendo che "senza questi dirigenti, senza l'esperienza della concreta organizzazione della lotta armata nelle città di Lione, a Marsiglia, progettare la formazione dei Gap sarebbe stato impensabile" <18.
I comunisti passati per la Francia costituirono lo scheletro dei Gap ma dovettero scontrarsi in Italia con i nodi già presentatisi ai comunisti francesi, il timore delle rappresaglie, l'impreparazione della classe operaia italiana a questo tipo di lotta, la scarsità cronica dei reclutati. Com'era successo oltralpe infatti, la previsione di versare alla lotta armata in città il 10% dei propri effettivi fu impossibile da realizzare per tutta la durata dell'occupazione. La direzione comunista decise comunque che bisognava agire e i più versati nella lotta armata furono impiegati nell'attuazione della direttiva, colpire e sabotare il nemico in città sin dalle prime settimane. Anche i problemi logistici sorti in Francia, la necessità di documenti falsi, armi, vettovagliamenti e appartamenti, si ripresentarono in Italia, aggravati però dalla mancanza di una struttura clandestina preesistente alla lotta, come quella del PCF. I finanziamenti per i Gap vennero dai contributi richiesti ai tesserati al partito, ma anche dalle cosiddette azioni di recupero, ovvero rapine in banca o assalti alle caserme fasciste, esponendo i patrioti alla mescolanza con criminali comuni e con individui di dubbia moralità.
Ad ogni modo, il 25 ottobre Longo, telegrafando a Mosca sulle novità dell'estate e l'armistizio, poteva riferire sinteticamente "Sta nascendo la guerriglia" <19. Infatti le risorse umane più attive del partito erano mobilitate: sotto la guida di Longo e Secchia, Scotti era ispettore generale incaricato dell'organizzazione della lotta in Piemonte, Lombardia e Liguria, mentre a Roasio spettavano il Veneto, l'Emilia e la Toscana. Ritroveremo molti dei militanti addestrati in Spagna e Francia incaricati della costituzione delle singole brigate, mentre Ilio Barontini, prima di assumere la responsabilità militare in Emilia, viaggiò nelle principali città italiane per dare consigli ai comandanti di formazione e insegnare come fabbricare gli ordigni. Come in Francia quindi, non si attese di avere i mezzi e gli uomini necessari alla lotta, ma furono ampiamente dispiegate le risorse disponibili, nella convinzione che bisognasse agire subito, poiché spettava al partito il compito di innescare la miccia per l'azione delle masse.
Il 24 ottobre Ateo Garemi e l'anarchico Dario Cagno colpirono a morte Domenico Giardina, seniore della Milizia a Torino, e, catturati in seguito all'azione, lasciarono spazio al I Gap del Piemonte, guidato da Giovanni Pesce. Le prime azioni di Garemi e Cagno, che, pur avendo avuto contatti con il partito, non ne dipendevano, rientravano nell'ambito di azioni di disturbo da parte di un gruppo anarco-comunista, i cui obiettivi risultavano abbastanza casuali, come per altre cellule autonome, ad esempio Stella Rossa. Appunto per portare sotto la propria autorità la lotta urbana, il PCd'I convocò a Torino Remo Scappini in qualità di responsabile federale, Arturo Colombi, responsabile regionale, e Romano Bessone, commissario politico dei Gap per la città <20. Tutti e tre militanti di vecchia data, i primi due passati per Mosca, per l'emigrazione in Francia e la detenzione a Civitavecchia, Colombi anche per il confino a Ventotene. Bessone invece era nato nel vercellese nel 1903, operaio comunista dalla gioventù, era stato deferito al Tribunale Speciale nel 1927 per aver partecipato ad una riunione comunista nei pressi di Torino. Resosi latitante, fu arrestato il 25 ottobre 1930 e condannato a 16 anni di reclusione e 3 di libertà vigilata, ridotti poi a 7 per amnistia, fu scarcerato nell'ottobre 1935. Al momento dell'arresto dichiarò di essere tornato da Mosca e fu trovato in possesso di volantini comunisti. Durante la reclusione, a partire dal '32, gli fu impedito di tenere corrispondenza con Elodia Malservigi, dattilografa residente in Russia che dichiarò di aver sposato con rito sovietico a Nowieltz nel 1928. La sua scheda personale riporta che in carcere "tenne cattiva condotta politica, appalesandosi pericolosissimo comunista. Pertanto è stato incluso nel 2° elenco di sovversivi pericolosi da arrestare in determinate contingenze" <21. Infatti, dopo l'ingresso in guerra, il 20 luglio 1940, era stato inviato al confino a Ventotene, dove aveva ripreso contatto con i dirigenti confinati e da cui sarebbe stato liberato nell'agosto '43, poche settimane pima di ricevere la responsabilità della formazione dei Gap torinesi. La direzione fu invece affidata al venticinquenne Giovanni Pesce, che abbiamo incontrato tra i giovani accorsi in Spagna sette anni prima. Al rientro in Francia era tornato dalla famiglia nella regione della Gran Combe ma, vista la difficoltà di trovare lavoro e il timore di essere internato per la propria condizione di straniero comunista, entrò clandestinamente in Italia e fu arrestato a Torino il 23 marzo 1940. Trasferito a Ventotene sei mesi dopo, vi trovò compagni vecchi e nuovi: "Terracini, Scoccimarro, Secchia, Roveda, Frasin, Camilla Ravera, Spinelli, Ernesto Rossi, Li Causi, Pertini, Bauer, Curiel, Ghini" <22. In assenza di militanti provati da versare alla nascente formazione, Bessone e Pesce si volsero agli appartenenti a queste cellule di fabbrica spontanee, comuniste ma non legate alla linea di partito, reclutando giovani provenienti soprattutto dall'ambiente operaio.
In Lombardia invece, il comando regionale era assegnato alla metà di ottobre a Vittorio Bardini, responsabile politico, a Cesare Roda, responsabile tecnico, e ad Egisto Rubini, addetto alle operazioni. Il profilo di questi uomini è quello spesso incontrato nel nostro percorso: tutti sopra i 35 anni, divenuti nell'esilio rivoluzionari professionali, passati per la Spagna, e Rubini anche per i FTP del Sud della Francia. In questi parametri generali rientravano tutti i comandi regionali e i principali istruttori dei distaccamenti, che si esposero in un primo momento per dare l'esempio ai nuovi, sotto i trent'anni, che sarebbero stati i fautori del terrorismo urbano. Il primo obiettivo di grande rilievo fu Aldo Resega, responsabile della federazione del fascio a Milano, colpito dal primo nucleo operativo dei GAP milanesi, che sarebbe diventato il distaccamento Gramsci (Validio Mantovani
Barbisìn, Carlo Camesasca
Barbisùn, Antonio La Fratta
Totò e Renato Sgorbaro
Lupo). Come rileva Borgomaneri, autore del lavoro più completo sul terrorismo urbano a
Milano, "il primo gappismo milanese nasce dalla fabbrica e affonda le proprie radici in quell'oscuro lavoro di agitazione, di propaganda e di proselitismo che l'organizzazione comunista è riuscita a tessere nel ventennio,[inoltre…] la prima forza combattente dei Gap è costituita da operai non più giovanissimi" <23. Essi erano infatti tutti operai dell'area di Sesto San Giovanni, il più giovane, Mantovani, aveva 29 anni, il più anziano, La Fratta, 35. I ragazzi, inesperti poco più che ventenni, sarebbero subentrati tra il gennaio e la primavera. Il 18 dicembre 1943, in concomitanza con uno sciopero che bloccava da giorni i principali stabilimenti milanesi, il federale venne atteso all'uscita della propria abitazione. La Fratta e Mantovani erano di guardia, uno accanto al portone e l'altro all'angolo della via, Camesasca e Sgorbaro nei pressi di un edicola leggevano un giornale, dietro il quale erano nascoste le armi. Resega venne colpito nel momento in cui il proprio cammino incrociava quello dei terroristi, che si affrettavano poi a raggiungere le biciclette e fuggire nel trambusto creato dagli spari. Le prime azioni, spesso improvvisate, rappresentavano per questi militanti, provati ma non temprati nella lotta, una prova del fuoco, lo scoglio da superare per altre azioni. Borgomaneri individua alla fine del '43 due distaccamenti, il Gramsci di Mantovani e il Cinque giornate di Oreste Ghirotti, composti ciascuno da tre squadre. Con le azioni iniziarono però anche le prime cadute. Il 19 dicembre Arturo Capettini, addetto alla logistica e ai rifornimenti di armi, fu arrestato. In seguito al rinvenimento di materiale bellico ed esplosivo nel suo magazzino di riparazione per biciclette, esso divenne una trappola per alcuni ragazzi del Cinque giornate, come Stefano Brau e Augusto Mori. L'individuazione di Sgorbaro portò inoltre all'isolamento del gruppo di Sesto, lasciando spazio alle azioni dei distaccamenti Matteotti e Rosselli, autori in gennaio di attacchi nei ritrovi tedeschi e mordi e fuggi in bicicletta. All'inizio di febbraio, per l'omicidio del nuovo questore di Milano, Camillo Santamaria Nicolini, fu richiamato il distaccamento Gramsci, del quale Camasasca e Mantovani erano stati promossi responsabile militare e politico. In questa fase più avanzata della guerriglia in città però, le autorità non si muovevano a piedi senza protezione: il piano prevedeva perciò di colpire Nicolini in auto da un'altra auto in corsa, una lancia Aprilia appositamente rubata a due tedeschi. L'azione, affidata ai giovani di Niguarda (Elio Sammarchi, Dino Giani e Sergio Bassi) ricorda ancora una volta come la riuscita di un colpo fosse questione di attimi, in cui non mancava l'intervento del caso. Un tram si interpose tra le due vetture e una frenata dell'autista di Nicolini impedì che venisse colpito. L'ultima azione di questa prima fase del gappismo milanese fu un attacco alla casa del fascio di Sesto San Giovanni il 10 febbraio 1944, compiuto con l'aiuto di un operaio della Breda infiltrato, Lacerra. Egli però, invece di lasciare la città (come previsto) si recò sul proprio posto di lavoro, dove fu arrestato due giorni dopo, portando ad una catena di arresti e delazioni che sbaragliò i gruppi di città, giungendo sino al vertice con la cattura di Bardini, Roda e Rubini. Quest'ultimo e Ghirotti si suicidarono in carcere dopo giorni di tortura. Il terrorismo urbano a Milano si sarebbe riacceso in estate, grazie alla riorganizzazione di Giovanni Pesce, che nell'inverno '43 era però ancora a Torino.
[NOTE]16 Santo Peli, Storie di Gap, op.cit., pag. 31.17 Amendola, Comunismo, Antifascismo, Resistenza, op.cit., pag. 364.18 Santo Peli, Storie di Gap, op.cit., pag. 33.19 Longo, op.cit., pag. 100-101.20 Nicola Adduci, Il mito e la storia: Dante Di Nanni, in Studi Storici, fascicolo 4, settembre-ottobre 2012, pag. 260-262.21 Acs, Cpc, fascicolo personale, busta 59122 Giovanni Pesce, Senza Tregua. La guerra dei GAP, Feltrinelli, Milano 1967, pag. 161.23 Luigi Borgomaneri, Due inverni, un'estate e la rossa primavera. Le Brigate Garibaldi a Milano e provincia. 1943-1945, Franco Angeli, Milano, 1995, pag. 24.Elisa Pareo,
"Oggi in Francia, domani in Italia!" Il terrorismo urbano e il PCd'I dall'esilio alla Resistenza, Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Pisa, 2019
.JPG)








.JPG)